

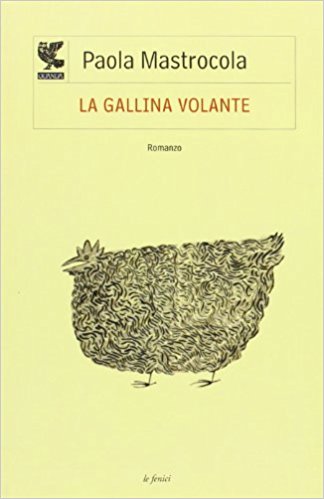
«Per quattrocento bruti, morti brutalmente!», sbotta Andrea Sperelli, infastidito dai manifestanti scesi in piazza in seguito alla strage nella battaglia di Dogali. La frase, ovviamente, costò molte critiche al Vate; che, da buon letterato qual era, rispose come qualsiasi romanziere potrebbe (anzi: dovrebbe) fare: «Quella frase è detta da Andrea Sperelli, non da Gabriele d’Annunzio, e sta bene in bocca di quella specie di mostro. Studiando quello Sperelli io ho voluto studiare, nell’ordine morale, un mostro». La letteratura, il romanzo soprattutto, da sempre hanno a che fare con i mostri, morali o fisici: non c’è nulla di male, il gioco funziona così, lo sappiamo. Nulla di male nel creare un personaggio brutto, o antipatico, o criticabile nelle parole e negli atti. Ed è una ingenuità, messa in conto dal romanziere ma non giustificabile epistemologicamente, sovrapporre la voce narrante con la figura dell’autore, attribuendo a questo gli stessi pensieri o atti del narratore (Marcel Proust, di cui si riparlerà, docet).
In questo suo primo romanzo Paola Mastrocola crea un personaggio per molti versi “mostruoso”: Carla insegna Lettere in un liceo torinese; ha superato la soglia dei quaranta, e vive la vita piatta e grigia di una insegnante un po’ stufa del suo lavoro. Le lezioni non se le prepara nemmeno, figurarsi: entra in classe, e secondo l’estro del momento ripete la stessa lezione che annualmente propina ai suoi annoiati studenti da un quindicennio. Di programmazione non vuol sentire parlare, mica ha tempo da perdere con queste piccinerie! Di lavorare con i colleghi men che meno: lei non lavora in nessuna commissione, al limite vorrebbe far parte della “commissione Proust”. Incontra settimanalmente dei genitori con i quali non riesce in nessun modo a entrare in comunicazione: alla maggior parte delle madri dovrebbe spiegare il perché dei fallimenti scolastici dei loro pargoli, dove sbagliano, che cosa potrebbero fare per migliorare, ma letteralmente non le vengono le parole; in un caso addirittura si spazientisce e alza la voce, non riesce proprio a giustificare alla signora Lasorgente un 3 assegnato a uno compito scritto, e conclude con un arrogante «la pensi come vuole: per me, tanto, il tema di suo figlio è 3» (p. 36). Almeno sarà una insegnante travolgente, come il professore del tanto amato (l’ha rivisto sette volte, dice) film L’attimo fuggente: macché, i suoi studenti, giustamente, si annoiano, alla ennesima riproposizione della identica lezione. «Strano che nessuno si metta mai in piedi sul banco a salutarmi, quando esco», si stupisce avendo in mente una delle scene più memorabili del film di Peter Weir (p. 27): e noi, che sappiamo che da quindici anni accoglie gli studenti nuovi con la stessa insulsa lezione sui nomi propri (pp. 30-31), che spiega il Verismo con infantili metafore ittiche (pp. 48-52), la struttura del periodo complesso (pp. 85-88) o l’uso delle virgole (pp. 121-122) con mezzi che sarebbero poco adeguati anche a dei bambini dell’asilo, e quando deve spiegare come si scrive un buon tema (pp. 141-142) se la cava in pochissimi minuti con un disegnino e la metafora di un verme fatto di anelli; noi, che assistiamo a tutto questo, lo capiamo benissimo, perché non si mettono in piedi sul banco. I suoi studenti sono pazienti, però («Sono anche gentili, gli studenti, sono cari», p. 17): pare che nessuno si lamenti, dei suoi sbotti di ira, dei suoi eccessi di sarcasmo durante le interrogazioni, dei suoi silenzi e delle sue risposte di comodo di fronte alle domande legittime (Ci insegna a scrivere? Ci dice esattamente che cosa vorrebbe che noi facessimo?). E quando, giustamente, le chiedono, dopo l’ennesima scena muta della povera studentessa “beccata” a non sapere fare il commento di una novella boccacciana, «Scusi, ma ce lo può insegnare, per favore», solo il suono del campanello salva l’insegnante balbettante, letteralmente, che fa scena muta proprio come la ragazza interrogata (pp. 17-18). L’insegnante Carla, che ci parla da questa sorta di diario di un anno scolastico scandito in un prologo, due parti corrispondenti ai due quadrimestri e un epilogo, ha una giustificazione per tutto ciò: «Voglio una cosa che non si può dire, né definire, né chiedere, una cosa che dovrebbe venire da loro, non da me. Sono gli studenti che dovrebbero saperlo che cos’è un commento, non io!» (pp. 16-17). Figurarsi! Ma lei, pare non preoccuparsi eccessivamente di questa sua patente incapacità didattica: anzi, lei, che è l’unica che entra nelle grazie del collega Canaria (uno strambo docente di matematica che va ripetendo che la scuola è piena di “bestie” e trasforma il suo disprezzo per i colleghi in una formula matematica che dimostra che all’aumento del numero dei professori diminuisce il “talento” per l’insegnamento), si sente molto superiore alle sue colleghe, che tanto si affannano a trovare gli strumenti migliori per insegnare: «dato che l’eccellenza, in tutti i campi, non può che essere raggiunta da un’esigua minoranza della popolazione, se tu allarghi il numero peschi nella maggioranza e quindi estrai dei pesci sempre meno eccelsi, più medi, più mediocri. E così abbassi il livello medio della classe insegnante. […] Io dico solo che il talento è una risorsa limitata, come il carbone peraltro, o l’uranio o la vegetazione. Non dico altro», afferma il barbuto Canaria (pp. 59-60). Lei, Carla, è invece, proprio come Canaria, una insegnate talentuosa, d’élite (non a caso insegna nella sezione A). E la stessa logica elitaria di Canaria lei la applica al suo essere insegnante (mestiere che, d’altronde, non voleva nemmeno fare, lo afferma recisamente più volte): «poi ti restano due o tre volti, due o tre nomi, non di più, si attaccano subito, ti rendono già familiare la classe» (p. 32). Sì, perché lei non è un “insegnante-pastore”, quello che si preoccupa che la sera tutto il gregge torni nell’ovile; lei vuole essere un insegnante-maestro, quello che se ne sbatte allegramente del gruppo, e si concentra solo su un esemplare, al quale trasmetterà un sapere iniziatico che gli permetterà di spiccare il volo. E per l’anno scolastico in corso questo esemplare si incarna in una alunna che, guarda caso, di nome fa Carla (come lei) Tannivella, detta Tanni, che è l’unica a mostrare un qualche entusiasmo per le sue metafore scontate e a essere capace, naturaliter, di scrivere un tema come si deve (che poi sia del tutto “fuori tema”, poco importa: il voto finale sarà comunque 9). Carla (la ragazza) riesce a infondere in Carla (la prof) la convinzione di essere davvero importante, di essere capace di insegnare e trasmettere un sapere ineffabile, che la trasporterà nel regno iperboreo dei pochi eletti. Vale la pena citare alcune frasi da una lettera-confessione che l’insegnante scrive (ma non inoltra) alla alunna prediletta, per la quale sviluppa una vera e propria ossessione affettiva (tanto che, in un folle disegno, a un certo punto pensa di adottarla):
ci sono i pastori e ci sono i maestri, e sono due cose ben diverse e se uno è in un modo non può essere nell’altro. I pastori sono gli insegnanti che tengono la classe come un gregge e stanno attenti a che tutte le pecore ci siano e li seguono, e se ne perdono una, o la aspettano anche mesi o tornano subito indietro a riprendersela trascinandosi tutte le altre, poi la accarezzano sulla testa, le asciugano la lana e la rimettono al suo posto. Ai pastori non importa niente dove si arriva, tanto non devono andare da nessuna parte: l’importante è tenere insieme il gregge. Il maestro invece è uno che insegna quel che sa che deve insegnare, e chi lo segue bene e chi non lo segue non importa, fatti suoi. Lui va diritto dove deve andare, intanto perché sa dove deve andare, e poi perché se facesse una deviazione anche piccola potrebbe non arrivare più dove deve e questo sarebbe grave; la sua strada è lunga e difficile, quindi non può distrarsi mai, nemmeno per vedere chi c’è e chi non c’è, certo il rischio è che può capitargli di arrivare solo alla meta e questo gli spiacerebbe proprio tanto. Lo so che sembra più simpatico il pastore, ma ti piacerebbe essere una pecora che poi nella vita non sa fare niente da sola e ha bisogno sempre del gregge? Almeno col maestro, quei pochi che lo seguono, fosse anche uno solo, arrivano in un posto dove poi saranno davvero individui, in grado di farsi la loro strada […]. Cara Tanni, mi dispiace ma io mi sento più di quest’ultima razza, e sarei felice se tu mi seguissi perché so dove portarti e so che lì ti troveresti benissimo. (pp. 162-163)
Si può essere più espliciti di così, nel declinare un programma didattico? Di sfuggita, si noti il rovesciamento del racconto evangelico del pastore e della pecorella smarrita, che implica una polemica contro un certo atteggiamento didattico che può incarnarsi nella Lettera a una professoressa ispirata da don Lorenzo Milani (cui Mastrocola, lo vedremo, ha dedicato tanti strali polemici in altri momenti; ma qui basti, a p. 10, la dichiarazione «Ho quarantadue anni, grazie l’ho già visto il Sessantotto» per marcare un disprezzo piuttosto evidente). Ma è bene anche notare, ad esempio, l’infelicità di una frase come «il rischio è che può capitargli di arrivare solo alla meta», con quel “solo” che oscilla nell’ambiguità fra avverbio e predicativo del soggetto (come deve essere: altrimenti la frase non ha senso) e denota un uso un po’ sciatto del linguaggio, tipico di tutto il romanzo (certo, è una lettera scritta da Carla sull’onda di una emozione fortissima, poi cestinata; ma rimane la sensazione di poco controllo).
L’abito didattico elitario si rispecchia poi nella attività principale di Carla, quella alla quale veramente si dedica con anima e corpo (dedicasse tanta cura e tempo all’insegnamento, sarebbe una insegnante molto migliore): l’allevamento di galline. Sì, perché lei non è una insegnante: lei è una allevatrice, dice spesso. O, anzi, è una insegnante-allevatrice; non in senso metaforico, proprio in senso letterale. Ma è un allevatore particolare: alle ventiquattro galline ha dato un nome (non a tutte, ovviamente: ci sono quelle che rimangono anonime, mica è un “pastore”, appunto), le coccola e le nutre con diligenza, non ha un interesse economico nella cosa. L’allegoria è scoperta: il pollaio è un gruppo-classe vero e proprio, gestito proprio come una classe di scuola; con metodi che, fossimo in un saggio più serio, potremmo accostare al comportamentismo più becero (e non a caso, nelle metafore di questa insegnante domina l’ambito degli animali). E anche qui, non conta il gruppo: ben presto Carla individua una gallina (Corvetta) alla quale dedicherà tutti i suoi sforzi, per potere realizzare il suo sogno: fare volare una gallina! Ovviamente anche questa è una facile allegoria: come gli studenti, cui la natura ha fornito una testa pensante, non sanno usare la loro mente per pensare correttamente, così le galline, pur dotate di ali, chissà perché non volano. E tutti gli sforzi di Carla vanno in questa direzione: riuscire, anche grazie a diverse “macchine da volo”, a fare volare almeno una gallina, da mandare a un concorso per la “Gallina Campione”. A questa attività Carla sacrifica tutto il suo tempo: al di là del lavoro scolastico (passa la maggior parte del suo tempo nel pollaio, figurarsi se le rimane modo di preparare qualche lezione o correggere), sacrificata sull’altare dell’allevamento delle galline è soprattutto la vita privata. Sì, perché Carla ha anche una famiglia: un marito, Mario, insegnante di matematica; e due figli, un bambino e una ragazza. I figli fanno una apparizione sporadica: compaiono solo tardi, nella narrazione, e verso di loro non c’è mai un moto di affetto, non diciamo amore; sono dei dettagli nella vita di Carla, che li percepisce al massimo come una perdita di tempo, e li affida tranquillamente alla baby sitter o alla solitudine. Questi figli dovrebbero essere nati dall’unione carnale con Mario, un noiosissimo e depresso personaggio che non si riesce proprio a immaginare unito nel coito con questa vera e propria campionessa di anaffettività. Carla si scalda e mostra un po’ di trasporto erotico solo nelle poche pagine in cui rievoca un suo antico fidanzatino, Michele, che non si capisce bene perché abbia mollato per mettersi con questo grigio burocrate dell’insegnamento. Tutta la loro vita è scandita dalla noia mortale: vanno a cena dai Bozzi, che Carla, dall’alto della sua brillantezza, definisce terribilmente noiosi (se tanto mi dà tanto…); si scambiano poche parole, di solito caratterizzate dall’incomprensione; come momento più esaltante di questa loro unione si concedono degli aperitivi con crodini e pistacchi (che lui, chissà perché, si ostina a chiamare pinoli): e sai la botta di vita! Mario è visibilmente depresso, e passa la gran parte del suo tempo davanti allo schermo del computer a “studiare” il sistema operativo Windows (come se ci fosse qualcosa da studiare in un sistema operativo nato proprio per essere usato da chiunque). Ma Carla non si pone poi troppe domande sulla questione: pensa solo, a un certo punto, di avere individuato il motivo di tale tristezza infinita proprio nella comparsa di Windows nel mondo dell’informatica. E qui ci sono delle pagine centrali, in tutti i sensi, che ancora una volta metaforizzano molto scopertamente la concezione del sapere di Carla:
«Vedi, una volta io programmavo in Basic, o in Fortran, o in SAS, e programmare voleva dire inventare e poi, piano piano, pezzo per pezzo, costruire; dovevo farmi un piano, capisci? Un disegno nella mente, completo, che andava dall’inizio alla fine, tutto già scritto nella testa, capisci? […] Non pensare che tutto ciò fosse elitario, era solo più faticoso. Ma sai la soddisfazione, poi? […] adesso per programmare hai i menù, ti parano davanti tre finestre di liste e tu devi solo scegliere: poggi il mouse qui o lì ed è tutto. È tutto un selezionare e basta. E sai qual è la cosa più buffa? che puoi anche non sapere che cos’è quello che stai selezionando, va bene lo stesso. […] È che per creare qualcosa tu devi conoscere. Avere una conoscenza a priori. Come fai a costruire qualcosa se non conosci nemmeno quello che selezioni?»
«E non potresti smettere di usare Windows?»
Infatti Mario rimpicciolisce gli occhi, ne fa due cerchiolini tristissimi, tondi come gli occhi di un bambino sfortunato […]; mi guarda e con un lento, lentissimo movimento semicircolare, come se avesse una sedia con le rotelle, vira di centottanta gradi esatti e si riposiziona davanti al computer, preme ON ed ecco si accende […]. Ci siamo. E in quel perfetto semicerchio di centottanta gradi modello goniometro io ho letto chiaramente come su una lavagna elettronica, lettera dopo lettera, il seguente messaggio: -allora-non-hai-proprio-capito-niente-è-inutile-che-ti-spieghi-non-vedi-che-il-mondo-va-così-non-è-mica-una-nostra-scelta-usare-windows-credi-che-possiamo-decidere-di-non-usarlo-forse?- (pp. 104-107, passim)
Lo stesso concetto è ripreso sotto dallo stesso Mario:
«Sai […], è come per la scultura moderna: una volta Michelangelo prendeva un blocco di marmo, lo osservava per giorni e giorni fino a che capiva che figura c’era dentro: se la vedeva nella testa, capisci? Aveva già idea di cosa tirar fuori. Invece oggi vai avanti così: togli un pezzo di pietra per volta e vedi che succede, a un certo punto decidi che hai finito e dai un titolo, non so: ‘Colpo di vento n. 2’ o ‘Testa di fauno’. Capisci? […] È tutto sullo stesso piano, capisci?»
Sì, tutto orizzontale. È come se ci fossero solo più coordinate nel periodo, sparite tutte le subordinate. (pp. 136-137)
Una mirabile banalizzazione di tutta l’arte post-classica, non c’è che dire; che sta benissimo in bocca a un insegnante di matematica depresso e, si direbbe, un po’ ottuso. I problemi nascono quando si prendono sul serio queste banalizzazioni, e magari le si usano per delle rischiose generalizzazioni socio-esistenziali. Cosa che puntualmente fa poche pagine dopo Carla, che con un notevole insight riesce a interpretare la tristezza della alunna Carla alla luce della teoria di Mario:
E improvvisamente capisco! […]
Ho capito perché Tanni è triste. […]
Tanni ha la stessa tristezza di Mario. Voglio dire, sono malati allo stesso modo.
A tutti e due hanno tolto il futuro.
Punto.
Tanni sta male come quando Mario fa scivolare tristemente il suo mouse sul tavolo.
Carla, era così semplice: non hanno più il futuro! Né Mario né Tanni.
Gli hanno appiattito il mondo, tutto in fila come i barattoli di un tirassegno. Come la mia spesa orizzontale, come le mie finestre: ognuna mi dà un pezzo di prato, ma io il prato intero non lo vedo mai.
Poveri giovani. Non possono pre-vedere, pro-grammare, pro-gettare. E così non sanno più cosa fare da grandi. Gli si aprono davanti decine di finestre, e in ognuna vedono un pezzo di qualcosa, ma quel qualcosa non lo vedono mai per intero. Stanno lì a guardarle tutte insieme quelle finestre, le tengono tutte aperte, in fila, orizzontali, e non sanno. Non sanno se preferiscono occuparsi di astronomia o chirurgia plastica, informatica o odontotecnica. Non lo sanno. Perché non mettono più le virgole, perché non glie lo insegniamo abbastanza.
Che è una dichiarazione di fallimento notevole in bocca a chi pretenderebbe di insegnare con una veloce metafora l’uso della virgola; ma soprattutto stona in bocca a chi ha già dichiarato di non avere scelto l’insegnamento, di esserci capitata un po’ per caso (se fai lettere, che altro puoi fare?) e di restarci dentro molto di malavoglia e per un calcolo di pura convenienza («Certo che gli insegnanti non è che lavorino molto», dichiara sin dall’inizio la voce narrante; ed è una notevole ammissione di colpevolezza, non c’è che dire). E alla luce di questa concezione, ovviamente Carla mostra un disprezzo assoluto per qualsiasi cosa contraddica la sua concezione del sapere e dell’insegnamento, riducendo a macchietta qualsiasi posizione diversa dalla sua (particolarmente odioso è il dialogo immaginario con un «allievo della Giuliani», pp. 166-169, nel quale emerge la superiorità schiacciante dell’insegnante Carla di fronte alle banalizzazioni delle colleghe di dipartimento nella verifica delle letture assegnate agli studenti).
Ripartiamo da quanto si diceva all’inizio: nulla di male, nel mostrare l’opera e i pensieri di una insegnante un po’ svogliata, poco disposta all’empatia, propensa a essere molto tranchant e un po’ manichea nel giudicare i suoi studenti. Una che offre ai suoi studenti delle lezioni rapsodiche e abborracciate, proprio come la cena («risotto ai funghi, gamberetti e rucola, Viennetta Algida […] cena raffazonata tra le 19.30 e le 19.55», p. 20) che offre alla suocera (che è talmente gentile da farle pure i complimenti e ringraziarla). Una che si lamenta pure, perché si sente tartassata dal lavoro («Orario del lunedì 8-13. Come sia stato possibile mettermi un 8-13 il lunedì, dico il lunedì. Chi fa l’orario mi odia. Vorrei essere al cinema. Invece sono qui, otto meno cinque. Adesso vado e parlo di quel che mi pare, la prendo bassa, che m’importa? Avrò il diritto di decidere, no? Potrò non averne voglia? L’impiegato medio se non ha voglia legge il giornale, prende il caffè, va in bagno, fa finta di leggere, fa finta di scrivere, fa finta di pensare. Noi no, noi mai», p. 47). Un “mostro”, appunto. Nulla di male, siamo in un romanzo, appunto; e il Vate potrebbe dire che quelle parole sono di Carla, non di Paola Mastrocola.
Senza dubbio, quando nel passaggio dal XX al XXI secolo fu pubblicato il romanzo, l’autrice Paola Mastrocola non era un nome noto: era ancora possibile leggere l’opera separando il personaggio dall’autrice; pensare che, d’accordo, magari l’autrice in carne e ossa poteva anche condividere qualcosa della sua collega e concittadina Carla; ma che, dannunzianamente, il suo intento poteva essere stato quello di mostrarci un personaggio comunque negativo (un “mostro”), che nella sua inerzia e pigrizia giunge al parziale fallimento dei suoi ideali: Tanni cambierà scuola, per seguire un suo futuro di calciatrice e andare dietro all’amore per un uomo separato con tre figli; ma la gallina Papera (che per sbaglio, però, lei ha registrato al concorso col nome della prima prescelta, Corvetta: lapsus di notevole significato) ha vinto il concorso “Gallina Campione” e il noto luminare olandese la vorrebbe come collaboratrice nelle sue ricerche all’università. Il guaio è che, dopo la pubblicazione di questo romanzo, Paola Mastrocola è diventata un personaggio quasi di culto per una frotta di Carle e Carli che vivono la scuola come frustrazione e sottomissione a un destino purtroppo inevitabile (come, appunto, è inevitabile usare Windows). E l’autrice, nei diversi interventi pubblici, dalle interviste agli articoli a quell’insostenibile pamphlet che è La scuola raccontata al mio cane (2004), non ha fatto altro che portare nel mondo un’idea di scuola perfettamente sovrapponibile con quella dell’insegnante Carla: fatta di lodi a un utopico passato in cui, magicamente, gli studenti sapevano scrivere benissimo e leggevano a tutto spiano; di rivendicazione di uno statuto quasi sacrale del ruolo dell’insegnante, che dovrebbe portare avanti un rito quasi mistico di iniziazione per quei pochi (anzi, magari per uno, o addirittura per nessuno) che hanno la fortuna di saperne comprendere il messaggio orfico; della teorizzazione dell’esistenza di un qualcosa di “ineffabile” che sta alla base del rapporto didattico, che non tollera alcuna esplicitazione o spiegazione (figurarsi la giustificazione delle scelte, figurarsi la programmazione!). Insomma, una posizione di comodo, che mette al sicuro l’insegnante da qualsiasi cosa possa minare la sua autorità (e al diavolo tutto lo sforzo di contrapporre all’autoritarismo della scuola l’autorevolezza di chi insegna: abbiamo una certa età, il Sessantotto lo abbiamo già visto, no grazie!).
E poi, diciamocelo fuori dai denti: stiamo parlando di un romanzo in cui non si spicca mai il volo. Nemmeno della gallina premiata vediamo mai il volo: il concorso si svolge a porte chiuse e, anzi, Carla stessa non è sicura che il premio sia stato attribuito proprio al volo. Anche Tanni, in forma parodistica, spiccherà il volo verso il suo futuro, ma la strada è ben diversa da quella tracciata dalla sua insegnante-pigmalione (che, infatti, la prenderà malissimo): diventerà una calciatrice, e il suo Alex, che commercia in saponette, la farà letteralmente volare sul suo dirigibile privato. E da una che fa delle continue tirate sull’importanza dell’espressione complessa (l’ipotassi contro la paratassi, insomma) ci si aspetterebbe qualcosa di più delle frasi semplici e banali che costellano tutto il romanzo. Da una che dichiara di volere far parte, se proprio deve, di una “commissione Proust”, ci si aspetterebbe qualcosa di più che la circolarità di inizio fine: come la Recherche si apre con la parola “tempo” nel «Longtemps je me suis couché de bonne heure» del primo volume e si chiude con il «dans le temps» del Tempo ritrovato; così questo romanzo si apre con il “beccata” che fa da ponte fra la tendenza a lavorare poco che accomuna Carla ai suoi studenti e l’allevamento delle galline, e si chiude con il fatto che, l’anno successivo, Carla viene finalemente “beccata” per le commissioni di maturità. Ma, appunto, nulla d’altro di proustiano c’è, né l’ardua sintassi ipotattica, né tanto meno le epifanie o la rappresentazione di un desiderio che domina le esistenze: al di là del fallimentare rapporto coniugale di Carla e del poco affetto per i figli, null’altro all’orizzonte; nemmeno nell’ossessivo rapporto fra insegnante e alunna, che si configura come un vero e proprio innamoramento, si apre qualche spiraglio di amore vero; il barbuto collega Canaria, col quale sembra condividere molto, non riesce a andare al di là di una macchietta un po’ piatta (e sì che, en abîme, ci viene pure detto che alle galline di Carla manca il gallo; e quando finalmente arriva, si tranquillizzano un po’). Un po’ piatte sono tutte le figure che compaiono nel romanzo: da quelli che puntellano la tristissima vita privata di Carla ai colleghi di scuola, ai quali piacerebbe somigliare molto ad alcune memorabili figure dei racconti scolastici di Domenico Starnone, che si stagliano però come un “falco alto levato” sopra queste galline con le ali tarpate. Nemmeno lo strampalato sogno di Carla di fare volare una gallina, preso come è in un desiderio di rivalsa (vincere un premio) e facile allegoria del rapporto didattico, riesce a sollevare questa figura “mostruosa” di una che è sconfitta dalla vita: il bovarismo che la domina (a un certo punto, p. 185, viene evocata proprio Parigi, questo “nome sconfinato”, direbbe la povera Emma) non giunge mai a farne una eroina tragica, come avviene d’altronde per i colleghi strampalati che perdono la vita a elaborare grafici o sognano di comprare un faro e andarci a vivere (cosa che, ovviamente, non faranno mai). Il personaggio più notevole del libro è, non a caso, il contadino Isidoro, che spicca nella sua semplice saggezza contadina e rappresenta, per Carla, una vera e propria parentesi di vita nel vuoto esistenziale che la circonda. Altro non c’è, nemmeno quella ironia e quel gioco con il linguaggio su cui tanto insistono i generosi commenti critici citati nel risvolto di copertina: le ironie sono sempre piuttosto scontate, i giochi linguistici di una banalità disarmante.
Vero e proprio iniziatore di una tendenza alla lamentazione e alla rivendicazione di un “ritorno all’ordine” (sintetizzato nel bel neologismo “mastrocolismo”, cui recentemente la studiosa di grammatica Cristina De Santis ha indirizzato una condivisibile risposta polemica dalle pagine del Sole24Ore, http://valenziale.blogspot.it/2017/03/uscire-dal-mastrocolismo-lettera-al.html ), il romanzo La gallina volante ci si dispiega oggi, dopo le numerose prese di posizione pubbliche della autrice, come una piacevole e poco impegnativa consolazione per chi vive quotidianamente il senso di impotenza e frustrazione ingenerato dall’insegnamento alle nuove generazioni. Vera eroina della piattezza e dalla incapacità di vivere una vita soddisfacente, Carla resta fino alla fine coerente con se stessa e ci traghetta nella palude di un anno scolastico che, lo sappiamo già, si ripeterà identico nella monotonia di anni e anni che saranno costellati solo da noia e insoddisfazione: che è la stessa che percepiamo chiudendo, finalmente, la copertina sulla pagina 213.
Dall’articolo di Cristina De Santis contro l’attacco supponente e arrogante della Mastrocola al “donmilanismo” citiamo qui la sua scherzosa definizione di “mastrocolismo”, termine che condensa benissimo un certo atteggiamento mentale di fronte alla scuola:
mastrocolismo s.m. tendenza dell’insegnante di liceo ad autorizzarsi attraverso un atteggiamento di severità accattivante, di passione autarchica per la materia unita a sprezzatura verso le tecniche didattiche e disprezzo verso studenti rozzi incolti e refrattari a capire e amare i testi del canone letterario e la grammatica tradizionale. Nell’insegnante della scuola di base si manifesta spesso nella tendenza a qualificarsi alzando incautamente l’asticella, ovvero anticipando contenuti complessi sotto forma di nozioni da incamerare per prepararsi al liceo. Si può incontrare anche in molti genitori ansiosi e invadenti, che chiedono alla scuola di essere rassicurati rispetto al loro sistema di attese.
Paola Mastrocola, La gallina volante, Parma, Guanda, 2000