

Due parole d’esordio.
«Ma, insomma, costui non ha veduto altro, nella guerra, se non cose da mettere in burla, gente scettica e sfaticata, superiori imbecilli?»
No, no. Ho veduto anche il resto. Tutto: il vasto dramma umano, la tragedia sanguinante. Garantisco che ho veduto. Ma oltre il dramma e la tragedia (già tanti e tanti li hanno detti e ridetti), c’era la commedia burlesca, c’era la farsa – anche la farsa – mattacchiona. C’erano, oltre i gas asfissianti, lacrimogeni, accecanti e variamente tossici, c’erano anche diffusi per l’aria, molti molti gas esilaranti. […] Anche perché, non si può essere eroi per quattro o cinque anni di seguito, e quando la guerra è diventata un atto di ordinaria amministrazione. Si è eroi, quando lo si è, per qualche attimo: non più che per qualche attimo. Prima e dopo, si è gente qualunque: e cioè gente che tiene ai suoi piccoli comodi, che gli piace stare allegra il più che può, e sgranchirsi un po’ la psicologia oltre che la fisologia, e sta a vedere con coscienza tranquilla come vanno a finire le cose. Adoperandosi, s’intende, ognuno nel suo piccolo, a che le cose finiscano bene.
Il tono del libro e le sue motivazioni sono dichiarate subito, esplicitamente. La prima edizione del libro Gas esilaranti. Taccuino della guerra burlona è del 1922. L’autore racconta in tono leggero, quasi da salotto, l’addestramento, il rapporto con i compagni, la prima esperienza della paura. I titoli dei capitoli riportano fedelmente tutte le tappe: E lei? Che viene a fare qui?, Il tirocinio del pappagallo, Diciamo pure ‘fifa’. Ma la fatica di mantenere un equilibrio nella scrittura che sia distante dal dramma e che sia spiritoso senza farsi satira o sarcasmo si sente subito. La storia frena e si avvita su se stessa proprio quando potrebbe farsi interessante. Non mancano comunque arguzia e ironia.
A prelevare i fondi.
[…] Se all’intendenza trovo quel solito maggiore che l’altra volta mi disse: «Se hanno freddo senza i cappotti, lo mettano per iscritto e domandino di scendere in pianura!», giuro che oggi mi faccio sgnaccare agli arresti. Bella voce marziale, quel maggiore! E bella testa!
Esito previsto del passo:
Cartone catramato: non ce n’è.
Chiodi e cavicchie: non ce n’è.
Filo di ferro: non ce n’è.
Badili: non ce n’è.
Mazzette da mina: non ce n’è.
Picconi: non ce n’è.
Tavole: «Vada lei stesso alla segheria, così e così, a sentire se gliele possono tagliare… fra sei o sette mesi». Sei o sette mesi? E gli uomini? Su già nevica. […]
Per invito di un collega: a una delle mense-ufficiali, numerose come le stelle del cielo e le arene del deserto, allogate questa in una chiesa, quella in una stalla, quell’altra in un cinematografo.
Il solito mediterraneo di broda con reliquie natanti di naufragi: qualche deperito rottame di spaghetto, qualche gonfia carcassa di fagiolo; e altre non molte pietanze, in cui la sostanziosa raffinatezza è armoniosamente sposata alla saggia economia raccomandata dalle ultime circolari. Matrimonio tra femmine: naturalmente infecondo. Il tutto, preceduto, seguito, e assiduamente interrotto da salti in piedi a bocca piena, concitate deposizioni di tovagliolo, viaggi intorno alla tavola e scrocchi di sproni dedicati ai superiori gerarchici. E poi, sorridenti strette di mano, senza numero, a colleghi sconosciuti. – Piacere… piacere… piacere…-
Sì: ma tanta ebrezza di conoscenze non mi farà dimenticare quanto questi molteplici contatti epidermici sieno condannati, soprattutto mangiando, dalla igiene meno esigente.
E poi, occhiate di intelligenza ai soldati-camerieri in giubba bianca; acclamanti risate ai motti dei superiori; schiamazzi di vituperio addosso al povero direttore di mensa. E, finalmente, uscita. […]
Dopo il racconto delle difficoltà dell’amministrazione e la riprovazione nei confronti dei soliti imboscati, Zucca racconta in prima persona le contraddizioni della retorica nei discorsi che deve tenere ai soldati prima della battaglia. Non manca nemmeno una (forse troppo) bonaria ironia nei confronti degli ufficiali alla ricerca di nastri turchini a buon mercato.
Il grillo dell’invenzione e l’acaro dell’eloquenza.
Ma ecco la sguaiatissima voce di quel simpatico bestione di caporale telefonista che, acclamando su uno sfondo di altre voci sicule sommessamente strepitanti, evoca il tenente Zucca fuori dal baracchino a esaltare ai soldati la grande vittoria di Gorizia.
La notizia della presa è giunta l’altro ieri sera. Un discorso l’ho fatto appena giunto: uno l’ho fatto ieri: quello che ora i miei fedeli cannonieri pretendono dall’eloquenza del loro comandante sarebbe dunque, il terzo.
Sarà il terzo.
Affacciamoci alla porta.
Ci sono già quelle birbe dei colleghi in agguato, pronti a unire il loro plauso al plauso della folla.
Ecco: già sotto gli abeti si placa il silenzio dell’attesa. Accidenti!
E io che forsennatamente odio il parlare in pubblico; io che da quella memorabile conferenza su Gaio Valerio Catullo che lessi in terza liceo, non mi sono mai arreso, mai, a neppur uno, mai, dei tanti lusinghevoli inviti ad ammaliare con la mia bella voce i «signori e signore», e, chissà anche le «Maestà» e certamente qualche «Eccellenza»: io che ho rinunziato «a priori» ad ogni ascesa politica per non parlare ai «cittadini» ovvero ai «compagni»; io che, insomma, appunto per esimermi una volta per sempre dal parlare, mi son buttato a fare lo scrittore; io mi trovo oggi a dover improvvisare discorsi di saluto per arrivi e di congedo per partenze, discorsi di ringraziamento, discorsi alla truppa illustrativi di circolari o di ordini del giorno, e perfino di grandi orazioni celebrative di vittorie: a non parlare di commemorazioni o… Tastiamoci le stellette.
Una cosa sola mi conforta: ed è che la mia oratoria, per quanto assai scarsa, non mi pare, tutto sommato, più scarsa dell’oratoria dei colleghi, superiori e inferiori. Perché, come ha cacciato in tutti i cervelli il vispo grillo dell’invenzione, la guerra ha insinuato in tutte le lingue dei combattenti l’insonne acaro dell’eloquenza. E non c’è «uomo di truppa» che, dopo affardellato lo zaino, non si senta di rivolgere qualche focosa parola ai compagni, in attesa del tenente, il quale, intracollata la bandoliera, rivolgerà un breve fervorino ai suoi bravi soldati, in attesa del colonnello che verrà più tardi, commosso, a dichiararsi fiero dei suoi subordinati, ufficiali, sottufficiali e soldati, in attesa del generale che sopraggiungerà all’ultimo momento a portare il suo vibrato saluto e il suo augurio di fortuna e di vittoria ai partenti.
E a mensa, i brindisi? I brindisi preceduti dal modesto «permettete a me, che non pretendo d’essere un oratore»… Dio di misericordia! Se guai l’avesse preteso, prima di mettere a bocca il bicchiere si sarebbe prosciugato, tutto, per spontanea e graduale evaporazione!
E, peggio ancora, quando arriva su un’automobile strombettante un oratore di professione incaricato dall’Ufficio di propaganda, e ci tocca mettere gli uomini in quadrato e fingere di ascoltare!
Ma bisogna uscire! Quella canaglia di caporale telefonista ha portato al parossismo l’entusiasmo evocatore degli artiglieri della 477 batteria d’assedio.
Bisogna uscire.
Dirò per la terza volta che noi «facciamo solenne giuramento ai gloriosi fratelli della Terza Armata, che quando anche per noi sonerà l’ora del cimento…».
Dio mio! È la terza volta che la faccio sonare questa non originalissima sonata d’ora! E sempre così, verso sera. Che Mercurio, dio dell’accorta e varia eloquenza, mi perdoni, mi pare proprio di essere una sveglia di quelle a buon mercato che si caricano e si scaricano press’a poco all’ora giusta, ma sempre con quella identica, stonatissima scampanacciata. Comunque, coraggio! (Si bussa, ora, discretamente alla porta e, da fuori, la voce di quel briccone chiama, sommessa e ossequiosa:«Signor tenente!… Signor tenente!») Coraggio! Mi conforta il pensiero che «il solenne giuramento» e «l’ora del cimento», detti bene, possono ancora fare la loro figura; e che si starebbe freschi se, per esempio, ogni nuovo governo, facendo il suo discorso-programma, dovesse dire cose diverse da quelle già dette dal suo predecessore; e che, anzi, nel mio caso particolare, ciò sarebbe stato una bella prova di coerenza di idee e di fermezza di propositi, e quindi, in ultima analisi, non avrebbe potuto che giovare all’autorità del comandante la batteria e crescere la sua statura morale di fronte agli eventi che maturavano… […].
Il verbo all’imperfetto ovvero follia del nastro turchino.
E anche questa è una malattia. Altro se è una malattia! E mi propongo di studiarla appunto come tale.
Come i tori nelle corride e come gl’indemoniati, un tempo, quando si prestavano gentilmente a far la réclame ai santi, vedono e vedevano tutto rosso, così il militare che ha disposizioni organiche alla follia della decorazione al valore, vede tutto turchino. Giudica della sua destinazione a un certo settore, giudica di un suo superiore gerarchico, giudica di un fatto d’armi o di una stoffa grigio-verde, guardando esclusivamente sotto quest’angolo visuale:
«È un settore un po’ brusco: un buon settore: almeno un ‘bronzino’ ci si cava».
«Il tal colonnello… Che tipo è? Ne fa proposte di nastrini pei suoi ufficiali?».
«L’ultima offensiva? Magnifica! Trentacinquemila morti, è vero: s’è dovuto ritornare sulle linee di partenza: ma una gran bella azione! Proprio bella. Sono stato proposto per un tondino d’argento…».
«Troppo chiara questa stoffa: il turchino non ci spicca…».
Ho conosciuto un ufficiale superiore, poveretto, che dopo due anni di guerra, non gli era ancora riuscito aggiungere un pezzetto così di seta turchina in testa alle sfilze di nastrini multicolorati (pareva un campionario di merciaio, pareva) ma imbelli, che si allineavano in più ordini sul suo ampio petto. Non c’era stato verso.
E inutilmente, a ogni volta che usciva in ricognizione o si avventurava in qualche trincea di prima linea o in qualche osservatorio avanzato, e arrivava qualche botta lì vicino, inutilmente, appena tornato al Comando, afferrava la penna e vergava.
Vergava una proposta per la concessione di un nastrino all’ufficiale che l’aveva accompagnato nella rischiosa impresa. E come atteggiava grandiosamente (oh vecchio Omero, dove sei?), quell’imperfetto nel quale – avete mai capito perché? – immancabilmente si redigono le proposte per le decorazioni al valore.
«… tra il folto grandinare dei proiettili nemici, coadiuvava impavido il suo colonnello nel rilievo delle posizioni, ecc. ecc.». Ovvero: «… sotto l’aggiustato fuoco di una batteria avversaria, con sereno sprezzo del pericolo preseguiva e conduceva a termine, a fianco del suo superiore, le osservazioni sui nuovi e importanti apprestamenti nemici, ecc.ecc.».
Calcolava, lui, il povero colonnello:
«Se impavido lui, impavido io: se sereno sprezzo lui, sereno sprezzo io: se nastrino a lui, nastrino, giurabbacco, a me!».
Invece questo calcolo, evidentemente astuto, era giudicato evidentemente ingenuo dai Comandi superiori; i quali, ogni proposta che veniva da lui, la mettevano, dopo risoci un po’ sopra, a dormire.
Ho conosciuto un capitano…
Ma no. Basta. Non voglio dir altro: per quanto, ci sarebbe da dire, credetemi, e da ridere un mondo, sulla malattia dei nastrini, e sulla sua applicazione di nerci nastrini per cura a certi toraci…
Ma non voglio che si dica: «Ecco: è per la rabbia che a lui non gliel’hanno dato!».
Non voglio assolutamente che si dica. E per ciò strozzo questo capitolo in fasce.
Dopo alcuni capitoli che scorrono via rapidi, dedicati alla vita quotidiana – Mania dell’obiettivo, Telefono da campo modello anzalone ovvero interpunzione della scocciatura quotidiana, Si farebbe ammazzare, Equivoci, Bum! Ovvero censura alle cannonate, Mensa ufficiali, Signorsì, signor colonnello!- si ha la sopresa di trovare il protagonista Finito tra i matti, come recita il titolo del capitolo. A dirlo in modo contorto sono le parole scritte a una donna, una piccola amica di Milano, a cui si racconta del viaggio alla ricerca di un ospedale, del ricovero e della diagnosi: astenia cerebrale.
La descrizione dei compagni, delle lunghe notti, della nostalgia di casa è composta, ma non ha nulla di umoristico, niente di ironico, è solo profondamente triste. La vena si è esaurita, è come senza fiato, sfinito. Rimane una volontà antiretorica, un’attenzione viva per la corporeità dell’esistenza, trionfante nel far scendere a terra nel grottesco anche la sofferenza, il trauma, la disperazione.
E alla fine del capitolo viene dichiarato falso perfino lo stentato tentativo di dare un’anima un po’ più leggera al racconto.
Il mucchio di panni sporchi non è che un giovanissimo aspirante della Teramo, la brigata del Vodice.
È un calabrese, magro e nero-fuliggine come un ascaro. Proprio su cima Vodice, proprio sulla tremenda quota 652, lo tirarono fuori, dopo un bombardamento di grossi calibri austriaci durato tutto un pomeriggio e tutta la notte, lo tirarono fuori accigliato ma tranquillo, così com’è ora da sotto un monte di cadaveri.
È terribilmente tragico e buffo: questo ragazzo in quelle eterne ore d’agonia in mezzo ai morti aveva fermamente stabilito un solo proposito: non «fare» mai più (la cacca). Infatti da che è qui all’ospedale si contano come giorni solenni e nefandi i giorni che «ha fatto»: che ha fatto costretto da violenze di uomini e di natura sproporzionatamente superiori alla sua volontà; quando fa, ah, quando fa, non si scappa mai abbastanza lontano! Ne ho avuto un saggio cinque giorni fa, io. Ed è sporchissimo. […]
Ma si capisce subito che questa forma epistolare è un ingenuo artifizio letterario: molto posteriore. Perché non c’è gozzo di lettore che se l’inghiotta, che nella prima metà dell’agosto del ’17, in quella squallida camerata del Convento delle Orsoline, io avessi voglia di scrivere lettere di questo tono a una graziosa amichetta di Milano.
No?
Dopo il ricovero, l’amaro ritorno al deposito, come lo definisce. E così racconta di una visione surreale, fascinosa e fuori tempo, che si fatica a credere realistica: i sette soldati grassi.
[…] A un certo punto il caporaletto di giornata, mettendo da parte sette generosi supplementi, disse al piantone di ripostiglio: « Questi sono pei sette soldati grassi!».
Presentata così la cosa, confesso che mi aveva fatto impressione: e la mia fantasia facilmente eccitabile di convalescente aveva visto quelle sette ignote figure di soldati grassi sfilare, una dopo l’altra, a passo di sogno, su uno sfondo di Vecchio Testamento. E mi aspettavo, con una attitudine inconscia dello spirito, che, per rispetto agli schemi della tradizione, qualcuno o qualche cosa, dopo una conveniente battuta di aspetto, m’avesse poi parlato dei corrispondenti sette soldati magri. Invece no. I magri non c’erano. Non c’erano che i grassi. E andate a parlar male dell’igiene e del vitto nell’esercito italiano!
Alla distribuzione del rancio io, ufficiale scrupoloso, sollecito della giustizia distributiva e, come ogni ufficiale in gamba, sospettoso di abusi da parte dei cucinieri, vedo portar via un marmittone traboccante di minestra. Fermo l’uomo con un gesto autorevole:
«Dove porti quella marmitta?»
«Signor tenente, è la minestra pei sette soldati grassi».
E due. La mia fantasia di convalescente ebbe un balzo. Rividi, su uno sfondo di Vecchio Testamento
(uno scenario di palme dipinte in nero su un cielo color porpora), rividi sfilare lentamente, in fila indiana, le silhouettes favolosamente corpulente dei setti soldati grassi. E i loro densi fiati di pachidermi, sbuffando a ogni passo nella fatica del camminare, velavano di sette nuvole ritmiche la trasparente lucidità dell’orizzonte.
Verso sera: « Signor tenente» mi fa il sergente di giornata «bisogna mandare un uomo dal sellaio a vedere se ha allungato i cinturini e le buffetterie per i sette soldati grassi: se no, domani non partono…».
Ah, per Dio! E tre! Ma dov’erano insomma questi sette mostri misteriosi di cui tutti parlavano e che io non riuscivo a vedere e che pesavano ormai con tutta la mole delle loro ipertrofie sulla mia eccitabile fantasia di convalescente? Si poteva finalmente tirarli giù, come mongolfiere alla fune, dalle nuvole del mito sul terreno delle cose reali? Dove diavolo stavano cacciati questi sette minotauri che si permettevano vilipendere le dimensioni normali, sforzare brutalmente tutte le misure, mangiare per ventotto e dar noie per quarantanove? Dov’erano? Che diavolo facevano? Erano esenti da tutti i servizi? Non avevano altro da fare che ingrassare ancora? Entra, in quel punto, in fureria un piantone stracarico di novissime monture grigioverdi e con in testa inalberata una pila di mostruosi berretti: «Ecco la roba» dice scaricando il tutto in un angolo «accomodata per i sette soldati grassi…».
[…] Giubbe (della misura più grande) triplicate, quadruplicate, a forza di giunte, cugni, raddoppi, complicate e rappezzate nel modo più assassino e ridicolo, e non – ahimè! – sulle spalle, ma sulla pancia, per far posto alla ventresca! Pantaloni (della misura più grande) a forza di fondi e di saette sforzati, gonfiati, moltiplicati, elevati al quadrato, anzi al… cubo, non – ahimè – per chiudere il nerboruto e guizzante volume della coscia, ma – oh, umiliazione, oh vergogna per l’artiglieria da fortezza, vergogna per tutte le specialità dell’artiglieria, vergogna per tutte le artiglierie, di tutti i tempi e di tutti gli eserciti, ineffabile vergogna dell’artiglieria nostra, alleata, neutrale e nemica! – per contenere il vile, il balordo, il sedentario flosciume! Per insaccare sette deretani inverosimili, offensivi, degradanti, da far salsicce e niente altro che salsicce, ma salsicce per i porci! […]
In attesa dell’ora della rivista, stamane ho fatto una piccola inchiesta. Dalla quale è risultato che, in tutta la Compagnia-Deposito, nessuno – dico nes-su-no – ha mai visti i «sette soldati grassi» ad eccezione di uno – dico u-n-o -, un vecchio territoriale che aiuta il sarto e che si rammenta di averli veduti, una volta, ai primi giorni del loro arrivo, circa un anno fa. Da allora, mai più: crede siano comandati ai lavori distaccati. Certo pel fronte non sono partiti..
«E come fate a dire che certo pel fronte non sono partiti?»
«Ah, signor tenente, se non si sono dimagrati!…»
«Lei ha visto, signor tenente, le monture che ci abbiamo accomodato ieri?» interviene il sarto, fermando il pesantissimo ferro da stiro (di quelli monumentali, con la brace in corpo) sulle vezzose pieghe di una giacca che sta arrangiando (chi non sa che è proibitissimo?) per l’elegante sergente maggiore.
«Ma possibile che sieno così grassi e non li abbiano ancora riformati?»
«E chi è che riformano, ora, signor tenente? C’è un mio fratello che ha un’ernia, vossia vede, grande accome questo ferro: e non è che lo vogliono riformare, sape…»
E più tardi, mentre ero in fureria a firmare dei buoni-viveri, si picchia, discretamente, all’uscio.
«Avanti!» faccio io, seguitando a firmare. Ma mentre firmo, ho il senso che la luce, nella stanzetta, si oscura e che l’aria si ingombra di… Alzo gli occhi mentre una voce profonda dice: «Siamo i sette soldati grassi, signor tenente…».
Ah, perdio, finalmente! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette! Uno più grasso dell’altro, uno più pancione, uno più goffo dell’altro, uno più ridicolo dell’altro, uno più vergognosamente dell’altro speculatore sulla sua deformità, che certamente da un anno si è venuta coltivando, giorno per giorno, con riconoscente amore. […]
E me li son visti sfilare, alla partenza, sudanti e sbuffanti e doloranti per inesistenti mali con un ultimo sottilissimo filo di speranza in chissà quale miracoloso intervento, affardellati fino al grottesco, uno appresso all’altro, come nella mia visione di Vecchio Testamento. Ma non c’era, a sfondo, il cielo luminoso d’Oriente: c’erano un centinaio di facciacce di compagni sghignazzanti su quella comica sventura.
«Purgati! Purgatevi!»
«Ce l’avete nello zaino la bilancia?»
«Aspettate che vi fotografo prima della cura»
«Addio, biscottino!»
E uno, crudele:
«A carnevale s’ammazza. Ci avete sei mesi di tempo!»
Allora il primo dei sette si voltò brusco per rispondere chissà che, ma inciampò e ruzzolò: e l’altro che gli veniva dietro gli rovinò addosso, e il terzo fu sopra i due, dimenandosi con tutto il suo armamentario. E gli altri quattro ad affaticarsi per rimettere in piedi quelle tre mostruose testuggini gesticolanti. E fu una montagna caotica di grasso gemente e sbuffante e una girandola di gavette e zaini e di pastrani e di tascapani, intorno alla quale una risatacciona senza freni e senza fine diceva quanto l’uomo è fratello all’uomo e come la pietà indulgente sia l’ospite più assidua, sia il fiore più fragrante del suo cuore ben fatto.
Congedo
E, con questa risataccia senza allegrezza, il mio taccuino ecco, si chiude.
Di appunti burloni, dopo questi, niente più.
Passai, stanco e perduto di malinconia, di ospedale in ospedale, di visita in visita, di collegio in collegio, di congedo in congedo… […]
Non era in servizio a Caporetto, non era nemmeno sul Piave. E forse allora invece di una prosa beffarda avrebbe potuto trovare la voce limpida del poeta.
Giuseppe Zucca nasce a Messina nel 1887. È autore di romanzi, racconti e opere teatrali che ebbero al tempo una discreta popolarità.
Nel 1926 Corrado Alvaro gli riconosce un style très gesticulé, maisavec des intuitions souvent heureuses (FRABETTI, p.10) e l’enciclopedia Treccani parla di «un umorismo in cui la malinconia finisce col prevalere sull’ironia pur vivace».
Nel 1926 fonda a Roma la casa editrice Il Fauno Giallo con il progetto di pubblicare libri umoristici italiani. Riesce a coinvolgere molti autori di valore: Luciano Folgore, Massimo Bontempelli, Amalia Guglielminetti, Trilussa, Achille Campanile, Marinetti. Ogni volume riporta un ritratto dell’autore (Galleria del fauno) e a ciascuno Giuseppe Zucca, direttore della collana, chiede: che cos’è l’umorismo? Le illustrazioni sono sempre interessanti e curate da autori di una certa importanza. Dopo il testo si trova una autocaricatura del disegnatore o un ritratto dell’autore (Lo specchio del Fauno). Fonda con altri la Fauno film di cui è direttore artistico dal 1935.
Muore a Roma nel 1959.
Riportiamo in questo numero nella sezione Testi due racconti di Giuseppe Zucca tratti dalle raccolte L’uovo dell’amazzone (1926) e I cavalieri del tartufo (1927) pubblicati nella serie del Fauno giallo.

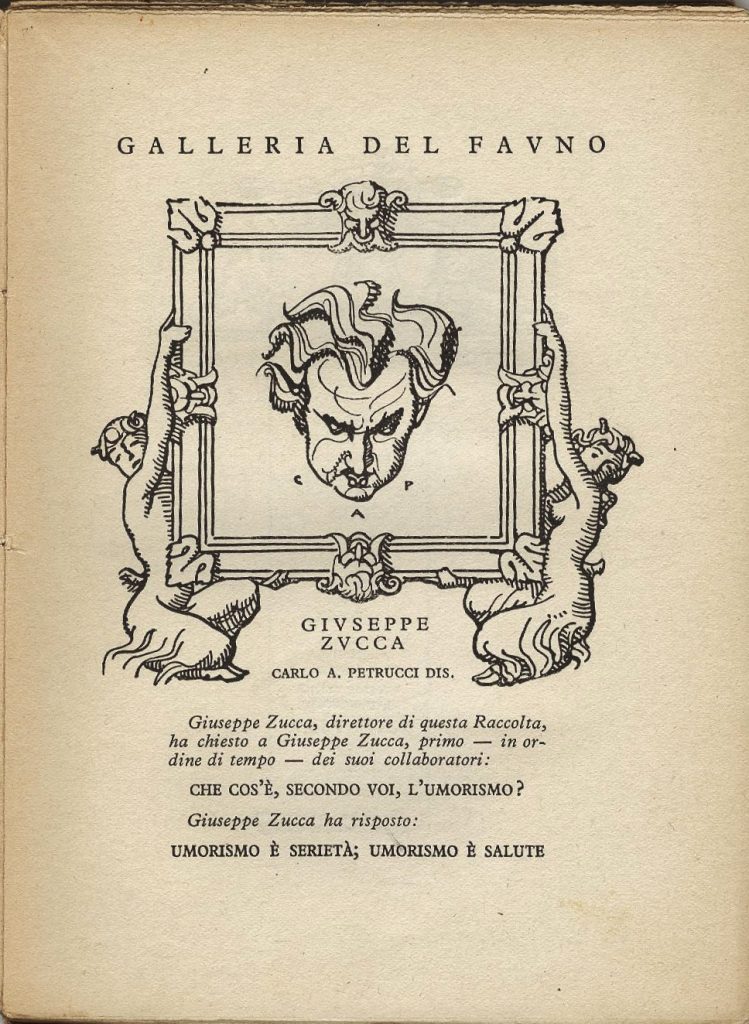
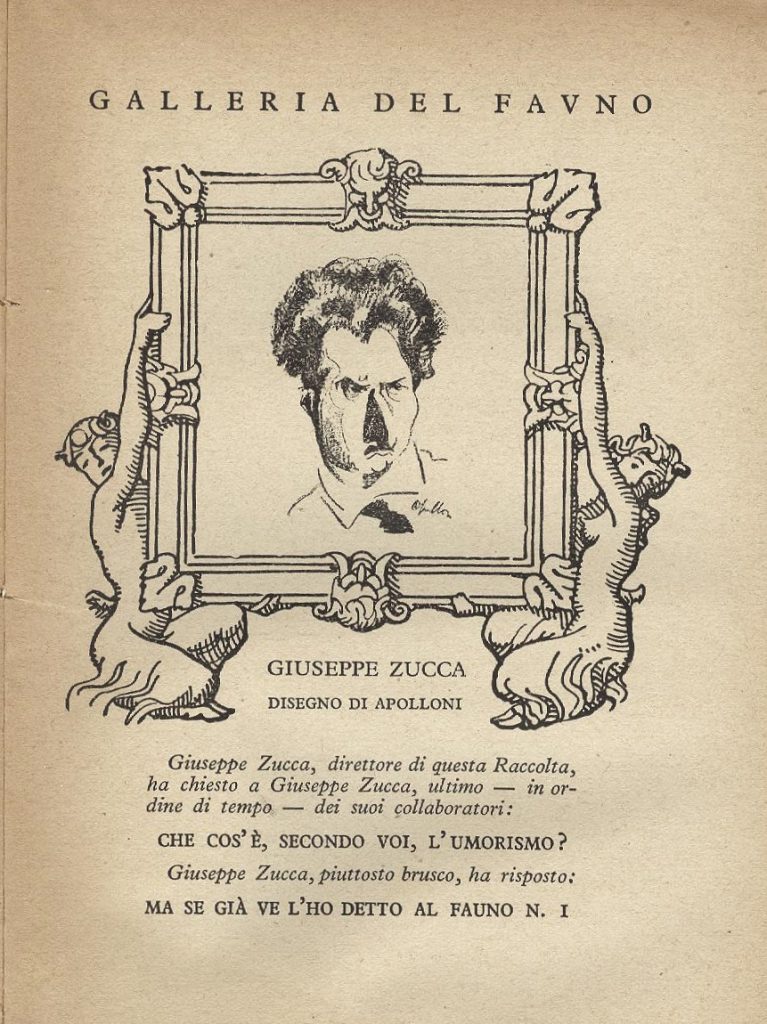
N. 1 Edizioni d’arte Il Fauno giallo (1926)
N. 2 Carlo A. Petrucci – caricatura di Giuseppe Zucca – Galleria del Fauno (1926)
N. 3 Livio Apollini – caricatura di Giuseppe Zucca – Galleria del Fauno (1927)
FRABETTI Anna, Note parigine di Corrado Alvaro sulla letteratura degli anni Venti
http://www.academia.edu/3467873/Note_parigine_di_Corrado_Alvaro_sulla_letteratura_degli_anni_Venti
http://www.academia.edu/3467873/Note_parigine_di_Corrado_Alvaro_sulla_letteratura_degli_anni_Venti
IANNACCONE Giuseppe (2003), I ricercati delle Edizioni d’Arte Fauno, in “Wuz”, n.7, pp.16-21
SCARANO Filippo (1957), Chi è? Dizionario Biografico degli italiani d’oggi, Roma
Notizie bio-bibliografiche ai link:
http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-zucca/
http://www.lfb.it/fff/umor/aut/z/zucca.htm
Tutte le trame e le schede dei film a cui partecipa come sceneggiatore sono al link:
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=112831
La poesia di Giuseppe Zucca La vanghetta del fante si trova in rete al link:
http://www.poesie.reportonline.it/poesie-di-novembre/poesie-on-line-giuseppe-zucca-la-vanghetta-del-fante.html