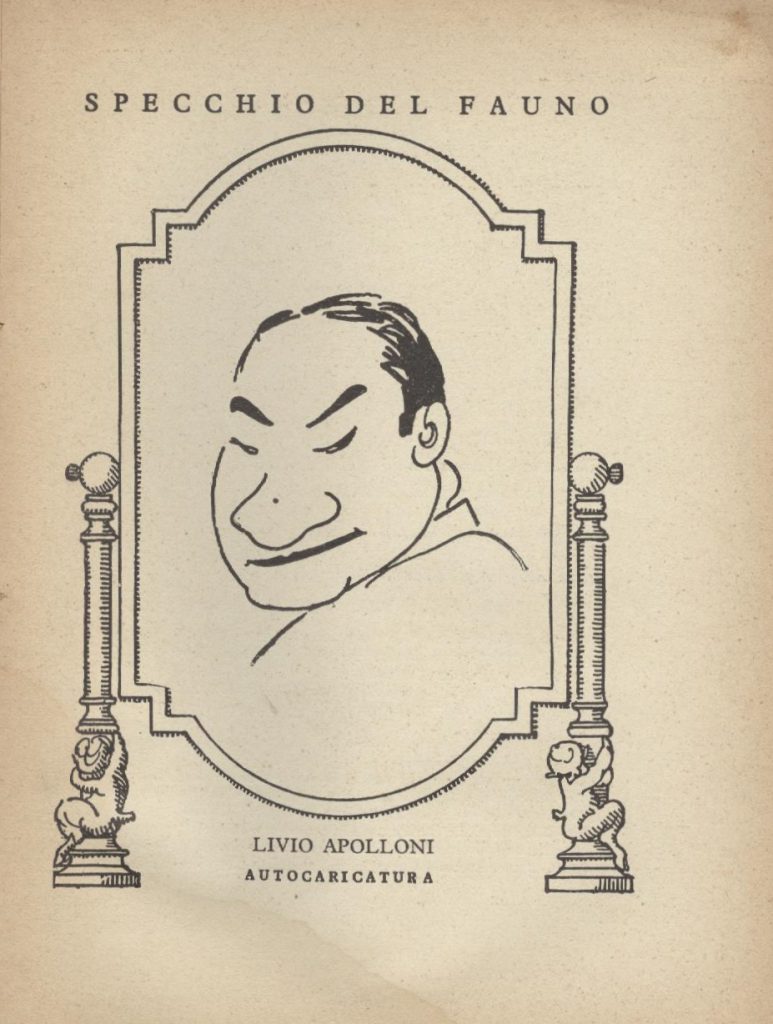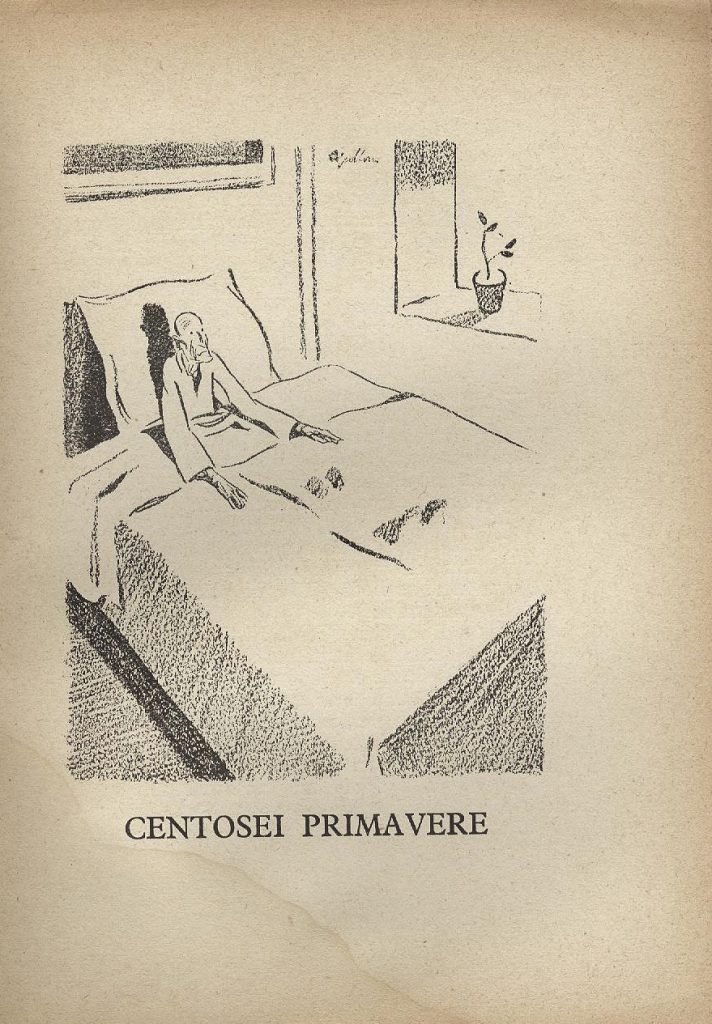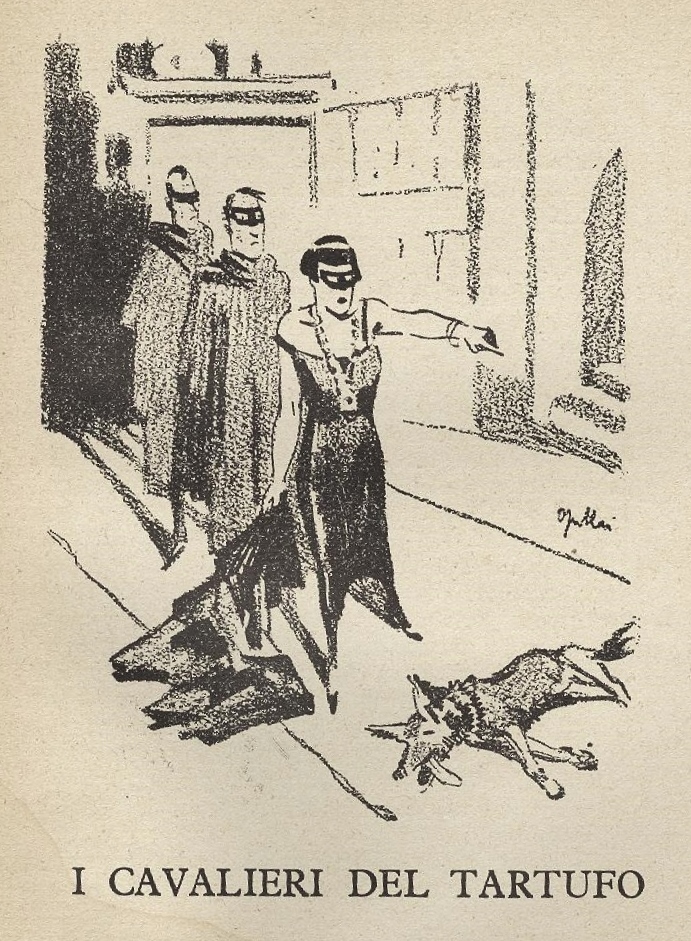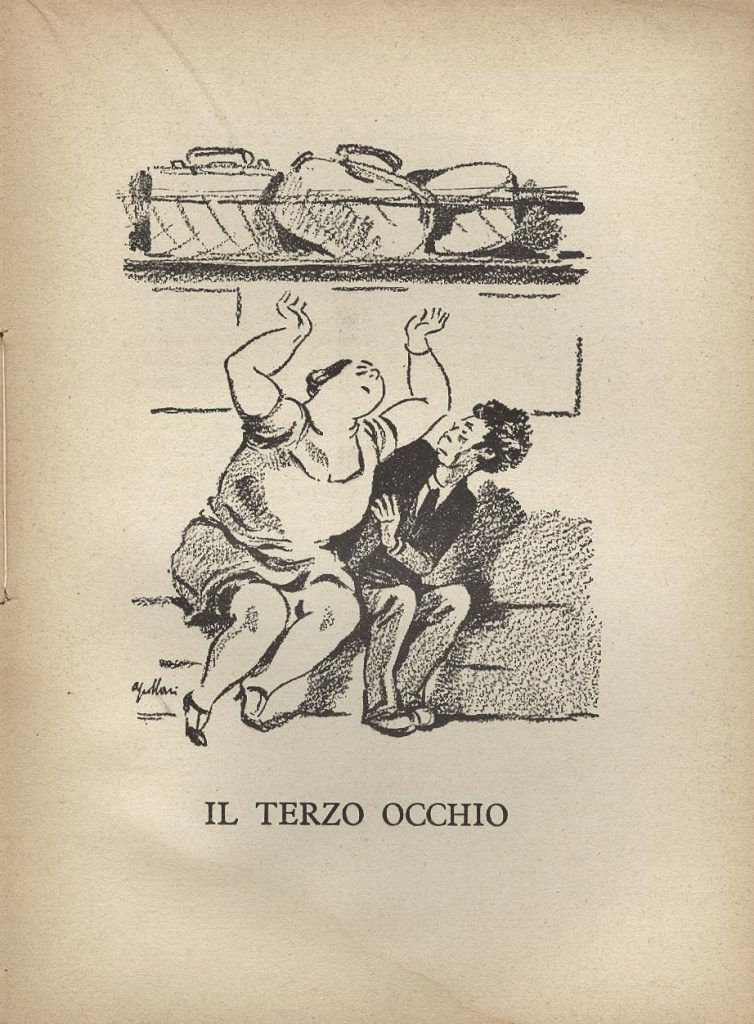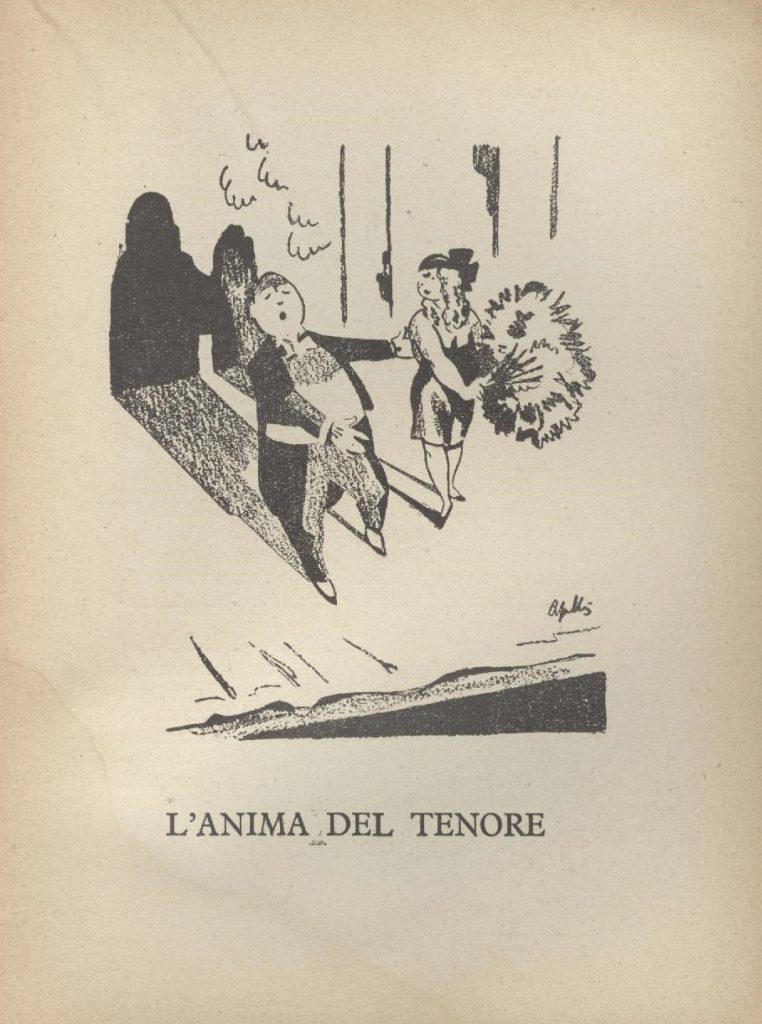[ Il racconto è tratto dalla raccolta I cavalieri del tartufo del 1927 con disegni di Livio Apolloni (Roma, 1904 – 1976) uno dei protagonisti dell’illustrazione e della caricatura italiana. ]
Strano che in tanta rinascita di pensiero, in tanto ardore di indagine e di specificazione, in tanta revisione di valori, in tanto svissceramento del più essenziale e intimo delle cose a cui, senza badare al tempo, attendono le generazioni più fresche e insieme più corrugate (avevo scritto «rugose» ma ho immediatamente corretto) di letterati e filosofi, nessuno abbia ancora pensato a rimettere, anzi a mettere, bene a piombo, sul suo legittimo piedistallo, quella grandissima fra le invenzioni del nostro tempo che è l’operetta – intendo l’operetta viennese e derivati -, a chiarirne le ragioni e le forme, a ricercarne i significati reconditi, a trarne gli ammaestramenti. Che sono grandi. Che sono giganti. Che sono supremi.
Io, che irresistibilmente rido alla grande opera lirica, che piango di non medicabile tristezza alla commedia in prosa, specie se arguta o gaia, io mi raccolgo nella più densa serietà e mi commuovo fin nelle più segrete latebre dell’anima all’operetta viennese e sottospecie e succedanei nostrani.
Ma il giorno della giustizia verrà anche per l’operetta. E sarà mio vanto, in quel giorno, come è oggi amaro e solitario orgoglio, avere per primo lanciato il grido della protesta e della santa rivendicazione. Per intanto, mentre i tempi lentamente maturano, mi piace delineare, a rapide linee sommarie, la nobile figura del tenorino dell’operetta, che è così campeggiante, complessa, ricca d’anima e di patetico interesse.
La parabola della vita del tenore, nei tre atti regolamentari dell’operetta, s’inarca su un fondale ben più vasto e di gran lunga più compòicatamente architettato che non sia quello di tela e cartone ritagliato e dipinto dallo scenografo e su cui la sua interessante figura si profila e si atteggia a suon di musica intermittente. È la legge medesima della vita che le fissa il punto preciso dello scatto, il punto supremo della curva, il punto preciso dell’arrivo. In tal senso intesa, la figura del tenore si ammanta di non so quali augusti paramenti sacerdotali: e pare davvero che celebri un rito.
Nel primo atto il tenore si innamora. Oh sì: egli è un bel giovine, ricco, spensierato, geniale: ha la vita facile, le conquiste pronte, l’avvenire raggiante di sole, profumato di primavera. Pure…Pure, quando a metà atto, gli appare l’amore vero, quello grande, definitivo, nelle vesti variamente drappeggiate ma quasi sempre opportunamente sobrie di una bella incognita, egli intende all’improvviso che la sua vita era vuota, illusoria, solitaria, pigra, disperata, e che la vita vera comincia il quel punto, da quello sguardo, con quel sospiro. Dategli torto. Egli, il tenore, ha ragione. Tanto è vero che l’atto si chiude con un suo appello appassionato e tremante di speranza, al bene intravisto e perduto.
Perduto. Perché, se così non fosse, l’operetta sarebbe in un solo atto. Il mistero della rivelazione, o uomini di poca fede, uomini che vi logorate nell’irrisione, che vi intossicate nel dubbio, il prodigio della rivelazione s’è compiuto. Il tenore ha ormai il suo avvenire segnato da un crisma di verità. Egli non ha che da seguire, in giubilo e in dolore, l’orma di Lei, dell’Eletta, dell’Unica, della Necessaria. Ed egli, nel secondo atto, coscienziosamente, instamcabilmente, attraverso difficoltà e prove di ogni genere, attraverso esaltazioni e scoramenti, in dolore e in giubilo la segue.
La segue ma non la raggiunge. Perché se la raggiungesse l’opereta sarebbe in soli due atti. È necessario, dunque, che il secondo atto segni il colmo del pathos. L’atto si chiude, infatti, con un appello disperato a colei che la malvagità degli uomini e l’avversione del destino vogliono separare da lui, per sempre. La parola del distacco e della rinunzia irrimediabile è prima detta, poi lungamente cantata, singhiozzando, nel finale del secondo atto. Nel quale una scossa di liberazione, un richiamo alla vita facile e spensierata, uno squillo di risa femminili, i profumi inebrianti del piacere, riconquistano il tenore, promettendogli l’oblio. Il tenore si getta, cantando e mirando con gli occhietti lucenti in alto, al loggione, nelle braccia della voluttà, ride e sghignazza sulle follie dell’amore, bestemmia il suo ingannevole sogno. Una coppa di champagne a buon mercato, colma avaramente a metà, brandita da una donnina dalla voce acerba ovvero dal «buffo» ubriaco ad oltranza che si elegge compare e gliela versa sulla camicia, ribattezza nell’orgia e nel peccato l’inconsolabile lutto del tenore.
Ma il terzo atto, punto di caduta della parabola, dà ragione all’amore e al sogno. La Eletta perduta è ritrovata. Gli equivoci sono dissipati. Gli ostacoli travolti, i nemici rotti e dispersi dall’invincibile amore. La felicità canta un inno a due voci, prima, poi a sei o sette con coro, alla generosa bellezza della vita, all’eternità dell’amore, perenne primavera sorridente sul Mondo.
E, checchè se ne dica, è giusto e necessario che questo accada nel terzo atto, perché, se così non fosse, l’operetta sarebbe di quattro atti almeno, e non di tre.
Per una anomalia della quale la gelosa Natura tiene la chiave del segreto, il tenore dell’operetta è, nella quasi totalità delle accezioni, piuttosto grassoccio.
Sotto la ben ravvolta cintura del nababbo indiano, sotto il lustro cinturino dell’ufficiale di marina, sotto il cinturone di cuoio del cacciatore o sotto il succinto panciotto del frac (ma sì, del frac, del frac, del frac, del frac!, sempre frac, nell’operetta viennese: si beve in frac, si dorme in frac, si pattina e si ruzzola in frac) immanvabilmente si arrotonda una proterva pacetta, che tenda insidiosamente infirmare il valore altamente patetico, sentimentale, romantico delle parole e del canto che la superiore bocca, ben rasa e ben rosa, va sillabando con così originale e leggiadra orteopia. Il tenore, certamente, si difende. Stringe, stringe, stringe: ma quel tanto che non può sopprimere, basta. E tristo alleato gli è quel soverchio delle ganasce che gli gonfia intorno al bocchino da sorcio e gli fa cercine intorno alle orecchie rosse come corallo e gli fa ressa dentro al colletto largamente rovesciato per far largo al ricco fluire delle note e della commozione. Ma inutilmente la vil carne nemica congiura ai danni del tenorre innamorato. Egli parla e canta come se i bargigli ed il collarotto e la pancietta non ci fossero. Parla di cose sottili e lievi. Canta la sua passione, il cui fuoco basterebbe a fondere ben altro grasso che quello trattenuto dai suoi tessuti con assai più effettivo dominio che dalla sua ventriera.
Discorre, il tenore, sorride, sospira, celia amabilmente, ma soprattutto definisce. Il tenore d’operetta è soprattutto un definitore. Per solito definisce a tutto vantaggio dell’ingenua amata, ignara della vita e delle sue leggi; definisce che cosa è la vita, che cosa è l’amore, che cosa la giovinezza, che cosa la rosa, che cosa la primavera. In tutto quanto egli afferma è un sapore acerbo d’impreveduto, un piccante modo di inquadrare e di distinguere, uno stile personalissimo che passa senza scosse e senza dubbi dal pittore all’inventore, dal miliardario allo scugnizzo, dal colonnello al ballerino. La definizione è sempre in musica. Ma è preceduta da un breve esordio parlato. L’attimo che intercede tra le ultime battute del sermo locutus e le prime del canto è accentato dal colpetto nervoso e arido della bacchetta del maestro su quadro del leggio. La pausa del silenzio che segue alla domanda piena di intenzione, sussurrata al roseo orecchio della bella intimidita e incatenata da un braccio amante e dall’attenzione sospesa, la pausa di silenzio, dico, è colma di perlessità, di attesa, e di un primo ondulamento d’anche delle masse corali femminili schierate discretamente sul fondo e che prepara, sorridente di complicità, le movenze del ritmo che sta per sbocciare.
– Perché tu, piccina mia, tu non sai cos’è la vita… –
Sorriso perlato e a vuoto della piccina che, col silenzio, confessa di non saperlo. Lenta occhiata inn giro all’altezza del terzo ordine dei palchi, lieve movimento di distacco del tenore che si curva verso la docile scolara piegando appena un ginocchio e tendendo e nervosamente puntando l’altra gamba sul tappetone saturo di pieghe e di polvere. Vivo di frittura del proiettore che sommerge nel suo liquido bagliore spettrale le due figure semiallacciate. Musica! Prima cifra della definizione: potenti svolgimenti della prima formula. Enorme sforzo mentale. Necassaria pausa di sollievo. Brevissima. Trionfo della verità bandita nel ritornello riprreso a due, poi raccolto dal coro, poi cantato, saltato, ballato e piroettato da tutto il palcoscenico con un insieme così spontaneo di consenso che veramente trascina:
La vita non è che un valzer
nel giro che tocca a te…
Questa sua qualità profonda di definitore, che è tutt’uno con la sua medesima essenza di pensatore, impedisce d’altronde al tenore di abbandonarsi senza freno alle danze accroccate dai settimini, ai grotteschi e agli sberleffi che inventa senza tregua il buffo senza dignità. Il tenore si mette sì, in catena, esegue sì, i suoi passi, sgambetta, salta, ma senza impegno, senza amore, come distratto: il suo vero io, la sua ansiosa anima è altrove.
La sua anima vera verrà fuori più tardi, libera e alata, filando tra naso e gola quelle sue note tenute su su su fino alla congestione, fino allo scoppio, fino al salto del bottone e allo scardinamento della cintura, con tutte le vocali ermeticamente chiuse, fuor da quel bocchino stretto stretto e lungo lungo come una serratura del buon tempo antico, praticato dentro quel faccione dipinto e rilucente che rammenterebbe tanto, ma tanto, il culetto paffuto dei poppanti, se non dicesse, come dice, gittandole a volo sull’ala del canto, le arcane parole dell’Amore e del Dolore e dell’amara saggezza e della insonne vita dell’Uomo, tristissimo Re in esilio, inconsolabilmente memore dell’ignoto regno perduto.