

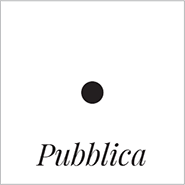
Il testo proposto, in lingua italiana o tedesca, lunghezza massima di 30 mila battute per i saggi, 12 mila per i racconti, deve essere corredato da un breve abstract in lingua inglese (massimo 900 battute) e da una sintetica biografia dell’autore/autrice (massimo 300 battute).
1. Formati di testo
Formato
Il testo può essere inviato alla redazione nei formati comuni dei programmi di scrittura (doc, docx, odt).
Carattere, corpo del testo, paragrafo
Il carattere preferibile è Garamond, corpo 12. Il paragrafo sarà con interlinea singola e giustificazione (la sillabazione sarà a cura della
redazione), nessun rientro a eccezione delle citazioni che superano le tre righe. Il testo greco va scritto in Times New Roman.
Varianti grafiche
Corsivo: è riservato ai titoli di libri, articoli e ai termini stranieri, esclusi quelli d’uso comune.
Grassetto: per sottotitoli del saggio, non nel testo
Maiuscole / minuscole
Attenersi alla massima uniformità cercando di ridurre le maiuscole all’essenziale evitandole quando non significanti. In ogni caso, una
volta compiuta una scelta, essa deve essere rispettata rigorosamente in tutto l’articolo.
Testo incolonnato
Nel caso in cui occorra presentare un testo su due colonne (ad es. versi in altra lingua affiancati da traduzione) si dovrà usare una tabella e non il tasto di tabulazione.
| Zum Beispiel... | Ad esempio... |
Citazioni (v. 4.)
Note
Le note sono a piè di pagina e a esponente, secondo il formato standard del programma di scrittura. L’esponente della nota va inserito,
senza spazi, dopo il termine interessato. Se segue un segno di punteggiatura l’esponente si pospone (esempi: Si tratta di una formula,2
più volte discussa.3 «Sono solo formule.»4). Per i riferimenti autoriali si prega di usare il sistema “all’americana” con
cognome dell’autore che rimanda alla bibliografia. Il numero di pagina può essere inserito senza scrivere p. o pag. (cfr. Autore 2008, 25). Anche i link
vanno inseriti come note.
2. Immagini
Invio
L’immagine va inviata separatamente e non inserita nel testo. Sarà cura della redazione inserire le immagini seguendo le indicazioni
degli autori.
Formato, dimensioni
L’immagine potrà essere nei formati comuni (jpg, tiff, ecc). Dimensioni del file: risoluzioni 300 dpi, massimo 3 MB.
Numerazione
Una serie di immagini da inserire va numerata nel nome del file e secondo l’ordine desiderato ad es.: gitanti.jpg, lago.jpg, colle.jpg,
vanno rinominati in: 01 gitanti.jpg, 02 lago.jpg, 03 colle.jpg, ecc. Nel testo invece si indicherà la posizione dell’immagine seguendo la
numerazione, tra parentesi, così: (Fig. 1 gitanti) (Fig. 2 lago) ecc.
Didascalie
Le didascalie vanno inserite nel testo tra parentesi, accanto al riferimento di immagine in questo modo: (Fig. 1 – gitanti) (Dida: Delacroix, Gitanti in barca, 1889).
3. Punteggiatura
Accentazione
Si prega di rispettare la distinzione fra gli accenti gravi: cioè, è, sarà, lassù… e quelli acuti: né, sé, perché, affinché, poiché, giacché...
Inoltre: È e non: E’.
Virgolette
Servirsi preferibilmente delle virgolette «caporali», mentre: «le virgolette “ad apice doppio” si possono usare all’interno delle citazioni».
Spazi
Dopo un segno di punteggiatura occorre sempre inserire uno spazio, esempi: non A.Manzoni ma A. Manzoni. Fanno eccezione i casi di
parentesi aperte (esempio uno); o virgolette aperte «esempio due»; oppure doppia iniziale puntata: J.M. Keynes, a.C. o c.d., e simili. Due
(o più) segni di punteggiatura consecutivi si scrivono uniti, ad es.: ecc.; oppure in chiusura di virgolette come in «esempio»; o parentesi
(altro esempio); o anche in casi rari come: Devo proprio dirtelo «Vattene!»?
Trattini
Trattino breve (-), da usare solo per le parole composte: video-conferenza, treno Roma-Bari. 1885-87, ecc.; trattino medio (–), da usare
per evidenziare incisi.
Parentesi quadre
Solo per riferimenti extratestuali come [N.d.T: ...], [N.d.A: ...] e per gli omissis […].
4. Citazioni normali e fuori corpo
Le citazioni brevi si inseriscono normalmente nel testo, con il medesimo carattere, tra virgolette basse, così: «Si definiscono fuori corpo le citazioni riportate come inserti distinti dal testo corrente [...]» (Lesina 2014, 250). Quando il passo citato supera le 3 righe, occorre andare a capo, inserire linea vuota, rientro a sinistra di 0,5 cm, ridurre in corpo 10, infine linea vuota. In questo caso non servono le virgolette. Esempio:
Si definiscono fuori corpo le citazioni riportate come inserti distinti dal testo corrente, normalmente rientrati rispetto ai margini della pagina […]. Per le citazioni fuori corpo non è necessario l’uso delle virgolette. (Lesina 2014, 250)
Queste citazioni rimandano alla bibliografia mediante riferimenti tra parentesi: Cognome autore e anno del testo citato, numero di pagina. Nei casi di più opere dello stesso autore uscite nel medesimo anno, si possono distinguere con lettera e ordine alfabetico. Es.: (Lesina 2014 a, 250) (Lesina 2014 b, 24).
Autori greci e latini
Per la citazione da autori greci si seguono di norma le abbreviazioni del Liddell-Scott, per gli autori latini quelle dell’Indice del Thesaurus linguae Latinae. Per tutti gli autori, sia greci che latini, le indicazioni di libri e capitoli vanno in cifre arabe, separate da virgole.
Esempio: Thuc. 1, 2, 1 = Thuc. libro I, cap. 2, § I.
5. Bibliografia
La bibliografia verrà inserita a fine articolo, all’americana. Si avranno in successione: cognome autore/i (o curatore/i) seguiti dal nome intero, in formato Maiuscoletto (o normale), l’eventuale indicazione tra parentesi: (a cura di) seguita da virgola, poi l’anno di pubblicazione tra parentesi, il titolo in corsivo, il luogo di edizione, l’editore.
Esempi:
Lesina Roberto (2014), Nuovo manuale di stile, Bologna, Zanichelli. (Oppure normale: Lesina Roberto (2014), ecc.)
Mori Massimo (a cura di), (2002), Filosofi tedeschi a confronto, Bologna, Il Mulino. (Oppure: Mori Massimo (a cura di), (2002), ecc.)
Specifiche:
6. Segnalazioni
Il titolo della segnalazione è composto dal nome dell’autore, dal titolo del libro, dalla città, dall’editore e dalla data, tutti separati da virgole; nome e cognome dell’autore della recensione seguono tra parentesi. Non sono ammesse le note.
7. Interviste
Nelle interviste la presentazione deve essere scritta in corsivo, domande e risposte non in corsivo.
8. Abbreviazioni
Il ricorso alle abbreviazioni è obbligatorio nell’apparato di note. Attenersi, per quelle qui rubricate, alle forme suggerite. Di norma, il plurale si ottiene raddoppiando l’ultima consonante.
Esempi: artt. = articoli; a.C. = avanti Cristo; ad es. = ad esempio; Bd. = Band; ca. = circa; cap. = capitolo; cfr. = confronta; cit. = citato; d.C. = dopo Cristo; ecc. = eccetera; éd. = édition, éditeur; ed. = edizione, edition, Editor, editio, editor; éds. = éditeurs; eds. = Editors; et al. = et alii (c.vo); fig. = figura; Hrsg. = Herausgeber; Ibid. = Ibidem (c.vo); Id., Ead. = Idem, Eadem; n. = nota; N.d.A. = nota dell’autore; N.d.C. = nota del curatore; N.d.T. = nota del traduttore; in genere non serve scrivere p. e pp. per indicare i numeri di pagina; p. es. = per esempio; s. e ss.= seguente e seguenti (e non seg. e segg.); t. = tomo; trad. = traduzione.